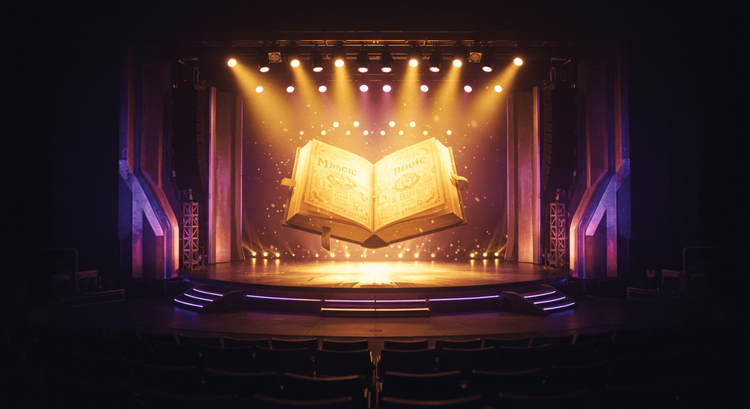Probabilmente, da questo periodo inizia lo sviluppo attivo di metodi e tecniche per l'uso della luce in una performance come elemento espressivo che organizza lo spettacolo teatrale, l'applicazione di tecniche di direzione dell'illuminazione. Inizialmente, lo sviluppo delle basi della direzione dell'illuminazione era principalmente teorico, poiché la sua piena realizzazione non era consentita dal basso livello di attrezzature tecniche dei teatri.
La corrispondenza del design della performance allo sviluppo emotivo dell'azione drammatica iniziò a essere considerata all'inizio del 20° secolo. "La decorazione dovrebbe attirare l'attenzione dello spettatore non come un quadro brillante esistente di per sé, ma al momento dell'azione, dovrebbe, senza rendersene conto, sentire l'impressione del quadro in cui si svolge l'azione."
Successivamente, con lo sviluppo della tecnologia teatrale, le premesse teoriche trovarono sempre più opportunità per l'implementazione nella pratica teatrale.
La base teorica della direzione dell'illuminazione fu posta nei lavori del grande riformatore della scena, Gordon Craig. Le prime performance musicali di Craig diedero un potente impulso a ulteriori ricerche ed esperimenti da parte di una grande coorte di direttori europei. "Nei primi lavori di Craig, apparve per la prima volta un nuovo modo di creare la forma scenica: la forma sorgeva interamente senza l'uso delle decorazioni nella loro forma precedente — per la sola forza del gioco espressivo dei cambiamenti di sipari di luce. Emerse un nuovo principio di costruzione della struttura della performance."
Il genio di Craig è così preveggente, le sue scoperte nello sviluppo di tecniche scenografiche e soluzioni per intere performance, specialmente del repertorio shakespeariano, sono così grandi che ancora oggi, nei lavori dei direttori, compaiono intere citazioni dai lavori di Craig, e i loro creatori possono anche non sapere che stanno citando Craig.
A. Y. Tairov sviluppa il problema dei "cambiamenti dinamici," "... che sorgono non a causa di un cambiamento visivo o un altro, ma a causa di un'estrema saturazione emotiva, inevitabilmente alla ricerca di una risoluzione dinamica." Già nella prima performance "Sakuntala," il desiderio di creare "un'immagine sintetica peculiare del testo di Kalidasa" porta all'uso dei principi del teatro indiano, dove "Il problema dei cambiamenti dinamici che ho posto può essere risolto sia attraverso una serie di adattamenti tecnici sia attraverso la partecipazione attiva della luce nell'azione.
Il ruolo della luce sul palco è indubbiamente ancora insufficientemente apprezzato da noi, e gli spiriti nascosti in essa non sono ancora estratti dalle lampade elettriche ermeticamente sigillate."
Un evento significativo nel lavoro di Tairov fu il suo incontro con A. Salzmann. All'inizio del 20° secolo, lavorando nella sala teatro educativa dell'Istituto del Ritmo a Hellerau, A. Salzmann (un artista teatrale, "ingegnere dell'illuminazione") usò una tecnica di regia non convenzionale: bilanciava il palco e l'auditorium con luce diffusa, evidenziando così l'azione, l'intensità del suono e la plasticità degli attori. "La luce diffusa — la luce del giorno senza il sole — esalta le sfumature dei colori e dona potenza espressiva ai contorni stessi."
"Le dinamiche della performance furono garantite dalla direzione dell'illuminazione di A. Salzmann: i pannelli luminosi che incorniciavano lo spazio dell'interpretazione, a volte opachi, a volte trasparenti, creavano un'atmosfera irreale; raggi colorati diretti, in assenza di fonti di luce visibili, apparivano quasi dal nulla. Onde di luce in movimento, soggette a un ritmo magico, avvolgevano le figure congelate degli attori in radiosità o le coprivano con l'ombra — così, forze superiori disponevano della loro vita e morte. Il concetto poetico di Claudel si incarnava qui nel simbolismo e nel ritmo della luce." Va notato che Salzmann lavorò a questa performance in stretta collaborazione con Adolphe Appia.
Ecco testimonianze dei contemporanei:
"Il nostro compatriota A. Salzmann, secondo il cui progetto è stata realizzata l'illuminazione della grande sala a Hellerau, è occupato nelle decorazioni per la prossima produzione alle celebrazioni scolastiche di luglio dell'"Orfeo" di Gluck.' E ancora: La produzione di 'Orfeo' di Dalcroze... aprì la strada... all'unica forma d'arte operistica. Nessuna scenografia: calicò grigio e blu sotto forma di sipari su diversi piani, discendendo sopra scale, gradini e piattaforme coperte di tessuto blu scuro...
Solo una forza, oltre all'uomo e alla musica, partecipò alla performance — la luce. Chi non l'ha vista non può immaginare cosa dia la partecipazione della luce, dei suoi crescendo e decrescendo nei crescendo e decrescendo della musica — la simultaneità e l'accordo delle dinamiche della luce con il suono —.
... Ma quando la luce si affievolisce sulle scene di malizia umana e oscurità spirituale, quando cresce insieme al 'crescendo' musicale e si risolve in radiosità sulle scene di vittoria e trionfo..." Nelle parole dei testimoni, sentiamo un'intensità di piacere estetico vissuto che può solo suscitare invidia nei partecipanti a questa azione teatrale.
In questa stessa performance, la luce "ha giocato il suo ruolo" nel senso diretto della parola. "Una delle applicazioni più interessanti della luce è il ruolo di Cupido. Cupido era invisibile; invece del consueto travestì con ali e faretra sulla schiena, sentivamo il canto dietro le quinte, e sul palco vedevamo un'intensificazione della luce."
Il desiderio di creare un volume scenico capace di realizzare "una performance emozionalmente tragica che si sviluppa nell'integrità e nella chiusura delle sue forme estetiche e soggetta alle leggi della sua espressività" fu l'idea principale di A. Salzmann.
Con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, A. Salzmann si trasferì dall'Austria a Mosca, dove partecipò attivamente all'apertura del Teatro della Camera di A. Tairov. Il loro lavoro congiunto determinò in gran parte l'unicità della stilistica delle prime performance di questo teatro. A. Salzmann continuò a sviluppare le idee iniziate con A. Appia a Hellerau.
La ricerca per creare una performance emozionalmente tragica che si sviluppasse nell'integrità e nella chiusura delle sue forme estetiche e fosse soggetta alle leggi della sua espressività portò al dramma lirico. "L'elemento emotivo del dramma lirico di N. N. Annensky fu percepito come un flusso di emozioni di ordine teatrale." Il design dell'illuminazione di "Fedra" mirava a creare una sorta di saturazione tridimensionale, sferica dell'atmosfera del palco con contenuti di colore. "La pittura, come modo di trattare la superficie di una costruzione o un'altra, fu sostituita dalla luce, saturando con la sua atmosfera di colore l'intera struttura dello spazio scenico... Il sistema ingegnoso di Salzmann, che posizionava le fonti di luce dietro orizzonti neutri e in diversi altri punti, consentì di materializzare in modo inusuale l'intero spazio aereo del palco e di riempirlo di contenuti cromatici mutevoli, in cui era immersa l'intera atmosfera del palco." In questo modo, il problema dell'illuminazione dello spazio scenico dall'esterno fu eliminato, e la luce divenne un elemento organico dell'atmosfera del palco.
"La scatola scenica, che è quasi una bara immutabile per molte ricerche, si aprì in muta impotenza davanti ai potenti flussi di luce che saturavano il modello," ricordò Tairov. "E ora le pareti scomparivano, e l'atmosfera luminosa diffusa cambiava colore, rispondendo alla minima pressione della leva di controllo."
"La luce solare e quella lunare non sono interessanti di per sé; ci interessano solo come forma elementare di esperienza emotiva." Questo peculiare paradosso di A. Salzmann potrebbe probabilmente appartenere anche a Tairov.
La scenografia come ambiente comunicativo tende alla fusione del visibile e dell'udibile con l'idea, super-obbiettivo e concetti della performance. Il desiderio di passare dai dettagli quotidiani a un livello superiore di comunicazione emotiva porta al problema di creare un ambiente oggetto comunicativo complesso sul palco.
L'ambiente complesso deve, se necessario, essere istantaneamente saturo di un'enorme quantità di segnali, punti di riferimento spazio-temporali, segni semanticamente pieni, simboli e immagini oggetto che rendano tangibile ciò che è soggetto alla percezione diretta. Deve anche liberarsi rapidamente, ripulirsi da essi in modo tempestivo, assumendo un aspetto completamente neutrale mentre mantiene la connessione interna e l'unità figurativa. Tuttavia, l'ambiente non dovrebbe agire come un dittatore o un suggeritore; il dinamismo non dovrebbe distrarre ma, al contrario, affinare la percezione dello spettatore dell'azione scenica, concentrando l'attenzione.
È importante avere una corrispondenza ideale della luce al suono e alla plasticità della performance, permettendo all'attore di interagire con la luce: sentire l'illuminazione, entrare nella luce, resistere o cedere al suo movimento. Si crea un ambiente luminoso mobile e espressivo, subordinato a una soluzione scenica unitaria.